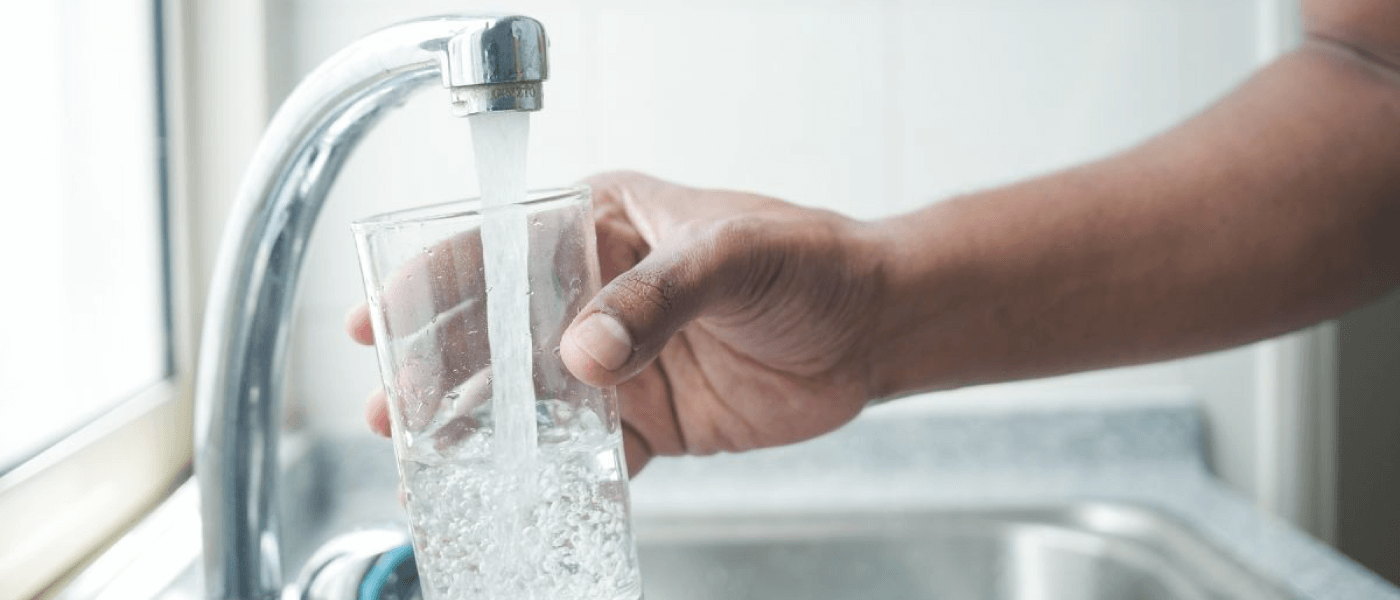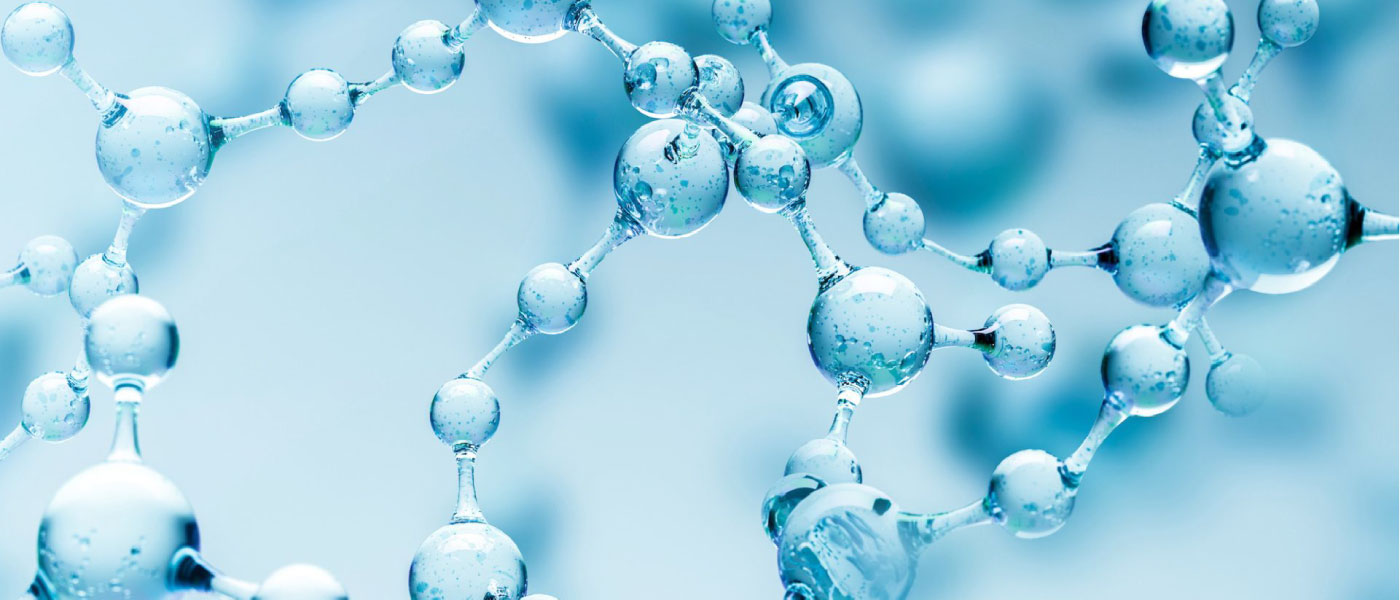PFAS nel vino è una questione che sta guadagnando sempre più attenzione. Ciò non riguarda solo la sicurezza degli alimenti e delle acque potabili, ma anche la bevanda che accompagna i nostri pasti. L’indagine pubblicata dal PAN Europe, nell’ambito della campagna “Message from the Bottle”, ha mostrato la presenza di PFAS, in particolare l’acido trifluoroacetico (TFA). Questa indagine è stata effettuata su vini provenienti da dieci paesi europei, inclusa l’Italia.
I campioni analizzati includono sia vini imbottigliati prima del 1988 e sia vini più recenti provenienti da diverse regioni. I dati emersi suscitano una riflessione approfondita sui percorsi di contaminazione lungo la filiera vitivinicola. In questo articolo trovi una sintesi dei risultati. Una spiegazione dei meccanismi di contaminazione, una valutazione dei rischi per la salute e l’ambiente, e una panoramica di soluzioni pratiche, con particolare attenzione alla purificazione dell’acqua che arriva sulle nostre tavole.
DATI CHIAVE DELLO STUDIO “PAN EUROPE” IN MATERIA DI PFAS NEL VINO
In questa sezione viene illustrata la distillazione delle cifre. Su 49 bottiglie analizzate, 45 contenevano tracce di TFA, provenienti da dieci paesi europei. L’esame ha distinto tra vini imbottigliati prima del 1988 e vini recenti. I vecchi campioni non presentavano PFAS nel vino, mentre i vini contemporanei evidenziavano livelli significativi di TFA.
La concentrazione mediana tra i vini recenti è di circa 110 µg/L, con picchi fino a 320 µg/L, registrati su un bianco austriaco del 2024. Per quanto riguarda l’Italia, tra i tre vini analizzati spicca il Chianti con 120 µg/L, seguito dal Prosecco a 69 µg/L e dal Kalterersee a 43 µg/L. Questi dati evidenziano un incremento dell’uso dei PFAS nelle pratiche agricole e di imballaggio nel corso delle decadi.
ORIGINI E PERCORSI DI CONTAMINAZIONE
I PFAS DEL VINO entrano nel vino, appunto, attraverso molteplici vie lungo la filiera. Dall’uso in fertilizzanti e prodotti agricoli, alla migrazione dal suolo alle radici, fino all’accumulo nei tessuti dell’uva. L’acqua di irrigazione, che può contenere PFAS provenienti da tubazioni, impianti di trattamento incompleti o reflui trattati, rappresenta un ulteriore canale di trasferimento. La contaminazione indiretta tramite l’acqua piovana, che dilava sostanze inquinanti presenti nell’aria vicino a fonti industriali, può depositarsi su suolo e foglie. Anche gli imballaggi hanno una storia nei PFAS. I rivestimenti e i componenti di bottiglie sono stati utilizzati in passato per le loro proprietà barriera. L’esposizione può interessare anche il vino biologico e biodinamico, a dimostrazione che la contaminazione ambientale è diffusa.

RISCHI PER LA SALUTE E L’AMBIENTE
Il TFA è una molecola ultracorta appartenente ai PFAS, noti come inquinanti eterni per la loro persistenza. I PFAS, inclusi TFA, sono associati a potenziali rischi per la salute riproduttiva, lo sviluppo fetale, il sistema endocrino e immunitario. Studi su modelli animali hanno mostrato malformazioni fetali in presenza di esposizione a TFA, alimentando preoccupazioni sulla salute umana. L’osservazione che i livelli di TFA nei vini recenti superino spesso quelli nell’acqua potabile rinforza la necessità di interventi lungo l’intera filiera. I dati indicano che i campioni storici non presentano PFAS. Ciò ci suggerisce un peggioramento legato all’uso crescente di PFAS nelle pratiche agricole e industriali.
QUADRO NORMATIVO E SCENATI POLITICI… NON SOLO PER I PFAS NEL VINO
A livello nazionale ed europeo si sta delineando una cornice normativa per i PFAS. In Italia, l’iniziativa Acque senza veleni ha portato maggiore attenzione sulle contaminazioni nelle acque potabili. Il governo ha approvato un Decreto-legge finalizzato a abbassare i limiti dei PFAS nelle acque potabili e a introdurre restrizioni sul TFA. Questo provvedimento è in attesa di passerelle parlamentari definitive. Molti osservatori chiedono una normativa zero-PFAS che vieti la produzione e l’uso di queste sostanze. Tutto per proteggere cibo, bevande e ambiente.
PURIFICAZIONE COME LEVA CONCRETA
Le soluzioni non restano teoriche. La purificazione dell’acqua rappresenta una leva chiave per ridurre l’esposizione ai PFAS lungo la filiera vitivinicola. A livello domestico e aziendale, la depurazione dell’acqua potabile può offrire una barriera iniziale contro i PFAS, inclusi alcuni TFA. Per affrontare una gamma più ampia di PFAS e trattare grandi volumi d’acqua impiegata in vigneti e cantine, servono sistemi di depurazione avanzati e ben progettati.
Le tecnologie disponibili vanno dal carbone attivo alle resine a scambio ionico, dall’ultrafiltrazione e nanofiltrazione agli impianti di trattamento avanzato (AAF), fino alle soluzioni ibride che combinano più tecnologie. Un impianto ben progettato deve considerare i volumi da trattare, la composizione delle acque e la gestione sicura dei reflui. In pratica, la depurazione non è solo una questione tecnica: è una sfida logistica ed economica che richiede pianificazione, manutenzione e monitoraggio costante.
VINO, IRRIGAZIONE E AMBIENTE: UNA STRATEGIA INTEGRATA
La purificazione dell’acqua, oltre a proteggere la salute pubblica, si inserisce in una strategia più ampia di tutela ambientale. Migliorare la qualità delle acque utilizzate per irrigare i vigneti, trattare i reflui provenienti dalle cantine e ridurre l’impatto ambientale complessivo rientra in un approccio sostenibile che assicura che il vino arrivi sulle tavole non solo gustoso ma anche sicuro. In questo contesto, la depurazione dell’acqua diventa una componente fondamentale della sicurezza alimentare e della protezione della biodiversità.

APPROFONDIMENTI OPERATIVI SULLA PURIFICAZIONE A LIVELLO DOMESTICO
Il contesto domestico rappresenta una frontiera chiave per ridurre l’esposizione ai PFAS legata al consumo di acqua potabile e all’uso domestico dell’acqua per cucina, lavaggio e irrigazione domestica di piccole aree. In molte famiglie, l’acqua di rubinetto può contenere PFAS, inclusi TFA, con variazioni in base alla regione e all’approvvigionamento.
Per affrontare questa problematica, è utile considerare soluzioni di depurazione. Queste soluzioni possono essere implementate a livello domestico in modo efficace, sicuro e relativamente economico. Le opzioni principali includono filtri a carbone attivo, sistemi di scambio ionico domestici, e, in contesti più avanzati, unità di ultrafiltrazione o nanofiltrazione integrate in impianti domestici o sotto-lavello. Il carbone attivo è spesso la scelta più comune. Questo grazie al costo contenuto e all’efficacia su una vasta gamma di PFAS. Ma, spesso, la sua efficacia dipende dal profilo di PFAS presenti. Ciò comporta la necessaria sostituzione periodica delle cartucce e gestione responsabile dell’uso di carbone esausto.
Le unità di scambio ionico offrono una rimozione mirata di PFAS. Esse possono gestire anche miscele complesse. Da tener presente che richiedono manutenzioni e un consumo maggiore di energia. Abbiamo le tecnologie a membrana, quali ultrafiltrazione o nanofiltrazione. Queste assicurano livelli di rimozione più elevati e una maggiore robustezza contro miscele di PFAS. Esse, però, comportano costi iniziali più elevati e necessitano di manutenzioni professionali. Oltre alle soluzioni hardware, anche una gestione accorta delle pratiche domestiche può contribuire a ridurre l’esposizione complessiva. Pratiche come la scelta dell’acqua di cottura, la riduzione del riscaldamento e l’attenzione a fonti di PFAS nell’ambiente domestico,
PFAS NEL VINO È UNA REALTA’ PROBLEMATICA
PFAS nel vino è una realtà che richiede azioni coordinate tra agricoltura, trasformazione, politica e tecnologia per proteggere la salute pubblica e l’ambiente. La strada comprende ridurre l’uso di PFAS lungo la filiera potenziare la purificazione dell’acqua e promuovere politiche pubbliche robuste che favoriscano trasparenza, ricerca e pratiche sostenibili.